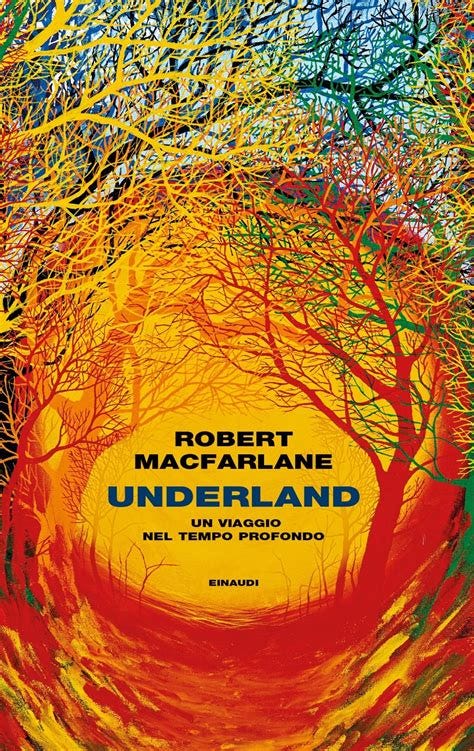Post domenicale #0
A proposito di mondi di sotto, di Antropocene e di cambiamenti in arrivo su Scritture e Nonfiction.it
In questi giorni sto leggendo, con qualche anno di ritardo, uno dei migliori testi di nonfiction degli ultimi tempi: Underland. Un viaggio nel tempo profondo, dello scrittore inglese Robert Macfarlane, uscito in originale nel 2019 e pubblicato in italiano nel 2020, da Einaudi, per la bella traduzione di Duccio Sacchi.
È una lettura che si addice molto al periodo novembrino, questo racconto dei viaggi nel sottosuolo che Macfarlane compie sotto la guida di scienziati ed esperti locali.
E accennarne – con la citazione più sotto di un paio di passi riguardanti il concetto di Antropocene (il termine, ormai ampiamente accettato dalla comunità scientifica, con cui si indica l’epoca geologica della storia terrestre che stiamo vivendo, «definit[a] dall’azione dell’anthropos, dell’essere umano, che plasm[a] la Terra su scala planetaria») – è anche un modo per me per provare a definire un po’ meglio l’impostazione che da qui in avanti vorrei dare a questo spazio su Substack e all’altro, ospitato su un blog WordPress, di cui – anche nel dominio personalizzato attuale – Scritture costituisce una costola, ovvero Nonfiction.it.
Scritture esordisce poco più di anno fa su Substack prendendo di fatto in prestito i (pochi) contenuti fino ad allora presenti su un blog sperimentale di Nonfiction.it intitolato Assaggi – scritture dal vero, il tutto per sfruttare le migliori opportunità di condivisione offerte da questa piattaforma. Da allora, è stato pubblicato o ripubblicato qui anche altro materiale, con buoni riscontri di pubblico. E visti questi risultati, per un periodo c’è stata anche, da parte mia, la tentazione di mettere completamente in soffitta il progetto di Nonfiction.it, in attesa di capire che cosa farne più di preciso, per concentrarmi esclusivamente su Scritture. Più di recente, però, pensandoci meglio mi è parso stupido far prendere soltanto polvere a questo bel nome di dominio di cui sono fiero proprietario da ormai dieci anni. Sono così pervenuto alla conclusione che valesse la pena spendere 50 dollari per associare a Scritture un dominio personalizzato che rimandasse proprio a Nonfiction.it e, in pari tempo, che lo stesso Nonfiction.it potesse continuare ad avere una vita propria, non soltanto simbolica.
Per farla breve, da qui in avanti avrei intenzione di pubblicare i contenuti più lunghi, in autentico formato longread/longform, proprio su Nonfiction.it, sia pur con cadenza sempre molto saltuaria, visto l’impegno che richiedono (specialmente se non ci si vuole limitare a riproporre materiali già apparsi altrove). Scritture dovrebbe invece farsi carico sia di pubblicizzare questi nuovi contenuti longread – con degli assaggi, per poi rimandare ai post originali su Nonfiction.it – sia di ospitare contenuti più brevi e di natura più varia (non ultimo, considerazioni sulle letture in corso, specie in originale, compresa la citazione di passi significativi), con una cadenza maggiore e se possibile più regolare, a mo’ di vera newsletter. In questo modo Nonfiction.it godrebbe di una sua maggiore visibilità e allo stesso tempo si eviterebbe di intasare con testi troppo lunghi le caselle email degli iscritti a Scritture che non usano la app di Substack (comoda e consigliatissima, detto fra parentesi).
È ancora tutto molto sulla carta, ci sono molti dettagli da mettere a punto (compresa la possibilità di prevedere donazioni occasionali tramite Buy Me a Coffee o simili, per sostenere il progetto Nonfiction.it), ma l’idea di massima su come procedere in futuro è quella appena enunciata.
E adesso torniamo al sopra citato Antropocene, nelle significative parole di Robert Macfarlane. Buona domenica!
Sono molte le ragioni per diffidare del concetto di Antropocene. Intanto è un concetto che generalizza le responsabilità di quelle che sono situazioni di sviluppo e di sofferenza molto diseguali. Il “noi” retorico dei discorsi sull’Antropocene minimizza la gravità degli squilibri esistenti, e universalizza le conseguenze specificamente locali dei danni ambientali. Inoltre definire quest’epoca l’“età dell’uomo” mi sembra un atto di automitizzazione, che non fa altro quindi che consolidare il narcisismo tecnocratico che ha prodotto la crisi attuale.
Al di là dei tanti difetti, però, l’idea di Antropocene ha anche il merito di dare una scossa forte, e lanciare una grande sfida, al nostro modo di percepirci in quanto specie. È un concetto che da una parte denuncia i limiti della nostra capacità di controllo dei processi planetari a lungo termine e dall’altra mostra le dimensioni delle conseguenze delle nostre attività. Mette allo scoperto alcuni fili di vulnerabilità e senso di colpa che fanno parte del legame tra noi e gli altri esseri viventi, oltre che tra gli esseri umani e quelli “più che umani” che verranno. Soprattutto, forse, l’Antropocene ci costringe a pensare al futuro in termini di tempo profondo, e a valutare che cosa ci lasceremo dietro, dal momento che i paesaggi che costruiamo oggi affonderanno negli strati geologici, diventando mondi di sotto. Che storia avranno le cose future? Che fossili lasceremo del nostro tempo? […]
Ma guardare avanti in termini di tempo profondo è un atteggiamento che contrasta con la nostra predisposizione mentale. Fate una prova, adesso. Pensate al futuro tra un anno. Ora tra dieci. E ora tra un secolo. L’immaginazione vacilla, i dettagli diminuiscono. Provate con mille anni. Cala la nebbia. Al di là di un secolo, immaginare uno scenario di fondo della vita individuale o collettiva diventa difficile, per non parlare di estendere la compassione a distanze di tempo ben più grandi, agli abitanti non nati di mondi futuri. Come specie, ci siamo dimostrati buoni storici ma scadenti futurologi.
Robert Macfarlane, Underland. Un viaggio nel tempo profondo, trad. di Duccio Sacchi, Torino, Einaudi, 2020, pp. 69-70.