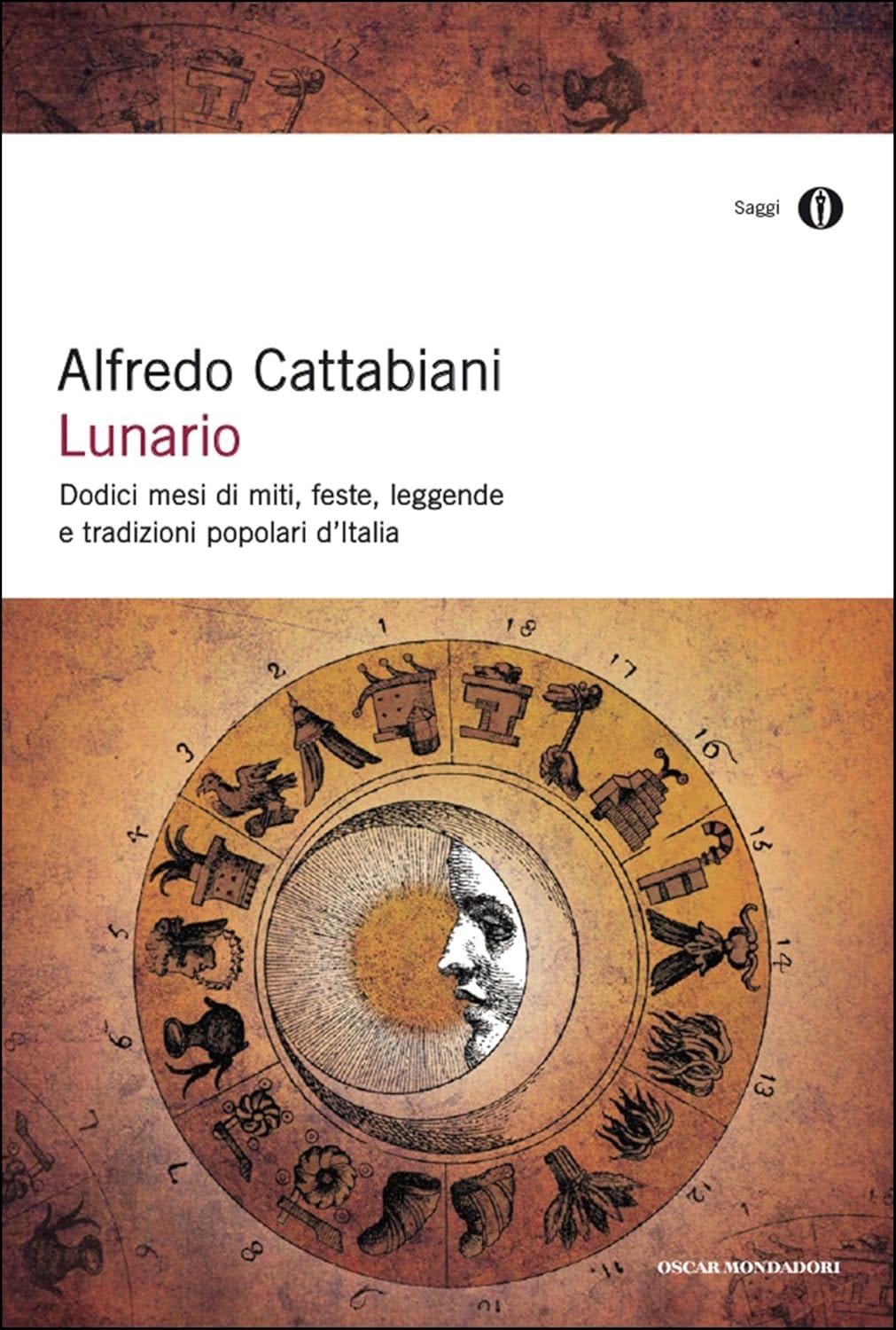San Martino
A proposito di tradizioni popolari, culti, leggende, credenze e proverbi del giorno di oggi, attingendo alle pagine di Lunario di Alfredo Cattabiani
Con San Martino, 11 novembre, vecchio capodanno contadino, finisce il periodo del Capotempo iniziato il giorno di Ognissanti e qui introdotto ricorrendo alle parole di Vittorio Monaco, dal suo Capetièmpe. Capodanni in Abruzzo (L’Aquila, Textus Edizioni, 2019).
Per chiudere in bellezza, solo per il giorno di oggi (poi rimuoverò il post), e riservato ai lettori online, propongo al riguardo un paio di pagine dal non meno pregevole e consigliatissimo Lunario. Dodici mesi di miti, feste, leggende e tradizioni popolari d’Italia, di Alfredo Cattabiani (Torino, 1937 – Santa Marinella, 2003).
Curatore di collane presso varie case editrici, in particolare Rusconi Libri, di cui fu il primo direttore editoriale, Cattabiani fu studioso di simbolismo, storia delle religioni e tradizioni popolari; tradusse opere di Simone Weil, Jules Barbey d’Aurevilly, Pierre Drieu La Rochelle e George Bernanos, e collaborò come critico letterario a giornali italiani e francesi. Oltre a Lunario (Mondadori, 1994; nuova edizione riveduta e ampliata, Oscar Mondadori, 2002), tra i suoi libri si segnalano Erbario (Rusconi, 1985), Calendario (Rusconi, 1988; Mondadori, 2003), Santi d’Italia (Rizzoli, 1993; BUR Saggi, 2004), Florario (Mondadori, 1996; Oscar Mondadori, 1998), Planetario (Mondadori, 1998; Oscar Mondadori, 2001), Volario (Mondadori, 2000; Oscar Mondadori, 2001) e Zoario (Mondadori, 2001).
Buon San Martino, lo festeggiate o meno!
«Far San Martino»
| di Alfredo Cattabiani |
L’11 novembre si suole ricordare che «L’estate di San Martino dura tre giorni e un pochinino». Spesso infatti, dopo le piogge dell’ultima decade di ottobre e dei primi di novembre, ritorna il bel tempo insieme con un po’ di tepore. Ma una volta la festa era popolare per altri motivi, come testimonia una locuzione proverbiale, ormai caduta in disuso. «Far San Martino» voleva dire traslocare, sgomberare, perché in questo periodo si cambiava tradizionalmente casa ed era anche il momento in cui scadevano i contratti agrari, tant’è vero che si diceva: «Per San Martino mandano via i contadini».
A San Martino, nell’Antico Regime, cominciava l’anno giudiziario, riprendevano le scuole, si riaprivano i parlamenti, si tenevano le elezioni municipali, si pagavano fittanze, rendite e locazioni e venivano rinnovati i contratti agrari.
L’11 novembre era giorno di precetto celebrato con fiere, fuochi e banchetti innaffiati dal vin novello. Anche per i bambini era festa grande, perché il santo portava loro regalini scendendo dalla cappa del camino o, se erano stati capricciosi, depositava una frusta ammonitrice detta in Francia Martin bâton o martinet: usanze tipiche dei periodi di Capodanno o di rinnovamento temporale.
A san Martino si dedicarono ben venti cittadine in tutta Italia, da San Martino Alfieri, in provincia di Asti, a Fara San Martino, in provincia di Chieti, dove la popolazione compie un pellegrinaggio al suo santuario raccogliendo nella valle delle pietruzze dette cicinelli che si conservano in casa come talismani oppure si gettano nei campi per favorire un buon raccolto.
Il culto e le usanze di San Martino sono di origine gallica perché egli morì a Tours, in Francia. La Francia, come d’altronde la Spagna e l’Irlanda, era popolata dai Celti che celebravano il Capodanno ai primi di novembre. E, tra le festività di quel periodo, fu proprio San Martino ad acquisire sotto il cristianesimo la funzione di Capodanno contadino, meglio del primo novembre, perché il vescovo di Tours fu nell’Alto Medioevo il santo più popolare d’Occidente e la sua festa era quindi la più adatta per cristianizzare le tradizioni celtiche di quel periodo che, segnando il passaggio dal vecchio al nuovo anno, durava dodici giorni.
Per renderlo più accetto alle popolazioni pagane che si stavano convertendo al cristianesimo si inventò la leggenda della cappa. Figlio di un militare, Martino aveva già la carriera tracciata: nel 332, a quindici anni, secondo le disposizioni degli imperatori Severo e Probo, era entrato nell’esercito diventando circitor, il cui compito consisteva nella ronda notturna a cavallo per sorvegliare le guarnigioni.
Una notte incontrò sulla porta della città di Amiens, nella Gallia, un povero tremante di freddo che chiedeva aiuto. Che fare? Non aveva nient’altro che la clamide di cui era vestito, perché aveva sacrificato tutti i denari in un’altra opera di carità. Allora, brandita la spada che aveva alla cintura, divise la clamide a metà e ne donò al povero la parte inferiore. La notte seguente, mentre stava dormendo, vide il Cristo che, vestito di una parte del suo mantello, diceva agli angeli intorno a lui: «Martino, il quale è soltanto un catecumeno, mi ha coperto con la sua veste».
Ebbene, nell’area celtica in cui il santo era nato e vissuto, e precisamente nella Pannonia, si venerava un “dio cavaliere” che portava una mantella corta. Era considerato il cavaliere del mondo infero, ovvero colui che vinceva gli inferi, che trionfava sulla morte. Perciò lo si considerava il dio della vegetazione che superava la morte attraverso la morte, e dunque il garante del rinnovamento della natura dopo la “morte” invernale: ne prova quella funzione anche la ruota, attributo tradizionale degli inferi, con cui è raffigurato nei monumenti trovati in Bulgaria, dov’è stato chiamato convenzionalmente il Cavaliere Trace. Cavalcava un cavallo nero e nera era la sua mantella.
Questa ipotesi interpretativa, suggerita da Margarethe Riemschneider e da me ripresa in Santi d’Italia, potrebbe permettere di capire il motivo dello sviluppo straordinario del culto di san Martino nelle Gallie, di cui fu l’evangelizzatore, e poi nelle zone limitrofe, compresa l’Italia settentrionale, che erano di antiche tradizioni celtiche. San Martino era dunque il più adatto a sostituire il veneratissimo “dio cavaliere”: non automaticamente, tuttavia, perché si doveva correggere iconograficamente il suo rapporto con gli inferi, che nella religione cristiana rappresentano il luogo della dannazione; perciò il suo cavallo è diventato bianco e Martino a sua volta combatte e vince il diavolo in tante occasioni, come testimoniano le leggende […].
Oche, castagne e vino
Una volta San Martino era anche tempo di baldoria, tant’è vero che si ammoniva: «Chi non gioca a Natale, che non balla a Carnevale, chi non beve a San Martino, è un amico malandrino». Ancora oggi nella pianura padana lo si festeggia con un banchetto dove troneggiano vin novello, oca e castagne. […]
Il vin novello è pronto per questi giorni. «Per San Martino si spilla il botticino», ricorda un proverbio. E un altro: «Per San Martino cadon le foglie e si spilla il vino». I piemontesi dicono: «Per San Martin a l’è da assagè l’ vin». E in Venezia Giulia: «Per San Martin in tute le boti se zerca el vin». Vin novello che, come sapete, è leggerino e va giù come l’acqua, ma proprio per questo è traditore, tant’è vero che un proverbio romagnolo ricorda che «Par Sa’ Marten u s’imbariega grend e znèn», per San Martino s’ubriaca il grande e il piccino.
Quanto all’usanza gastronomica dell’oca, si sostiene che si ispira a una leggenda. Quando san Martino venne eletto per acclamazione vescovo di Tours – era il 371 – si nascose nella campagna perché preferiva continuare a vivere come monaco. Ma uno stormo di oche rivelò con le sue strida il nascondiglio agli inseguitori. Secondo un’altra interpretazione le oche selvatiche migrano verso sud all’approssimarsi dell’inverno, sicché ai primi di novembre è facile cacciarle.
Tuttavia non è irrilevante per capire questa usanza il fatto che l’oca fosse un animale sacro ai Celti, simbolo dell’aldilà e guida dei pellegrini, ma anche della Grande Madre dell’universo e dei viventi. Un’eco della credenza è rimasta nel gioco dell’oca, di origine celtica, cha ha al suo centro come meta finale proprio quest’animale. A loro volta i maestri costruttori delle cattedrali gotiche, discendenti dei Celti, avevano adottato come distintivo di riconoscimento una zampa d’oca e fra di loro si chiamavano jars, oche.
Le castagne a loro volta sono un cibo collegato ai morti che, come già si è sottolineato, riaffiorano nel mondo dei vivi nei periodi di “capo d’anno”. A Marsiglia, in Francia, si dice ancora adesso che bisogna nascondere qualche castagna sotto il cuscino per evitare che gli spiriti dei morti vengano di notte a tirare il malcapitato per i piedi. Una volta in Piemonte, come in altre zone dell’Europa celtica, nella notte fra il primo e il 2 novembre i contadini lasciavano delle castagne su una tavola di casa perché i poveri morti potessero nutrirsene.
[…]
San Martino patrono dei cornuti
Alcuni proverbi presentano san Martino come il patrono dei mariti cornuti. «Chi cià moje, tie’ pe’ casa san Martino», oppure «Chi cià er marito vecchio e lo spasseggio der paino, de certo attacca er voto a san Martino», chi ha il marito vecchio e la corte di un giovanotto, certamente attacca un voto a san Martino. Perché san Martino è diventato il patrono dei cornuti? Un proverbio romagnolo rammenta: «Per San Marten volta e zira, tôt i béch i va a la fira», per San Martino, volta e gira, tutti i becchi vanno alla fiera. Si sostiene che, siccome una volta in questo giorno si svolgeva la fiera più importante degli animali cornuti, mucche, buoi, tori e capre, la fantasia popolare avrebbe collegato assurdamente gli animali cornuti di San Martino ai mariti traditi promuovendo il santo francese a ironico patrono dei becchi.
Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi hanno proposto un’interpretazione del fenomeno meno letterale, ma non sappiamo fin a qual punto fondata. Val la pena tuttavia di registrarla. Con San Martino si concludeva anticamente il periodo di Capodanno, le dodici notti di sfrenatezza carnascialesca prima della “Quaresima minore”, il periodo dell’Avvento, che durava fino a Natale. Quella notte in Romagna i mariti notoriamente traditi dovevano recarsi, secondo la credenza popolare, alla “fiera”, un luogo notturno di raduno da cui tornavano con difficoltà perché venivano braccati, derisi e cacciati da turbe di ragazzi. Un altro proverbio ricordava: «I béch per San Marten i ’n ciapa mai palèn, e int l’andêda e int l’artó i s’ingavâgna tra al côran», ossia i becchi per San Martino non ne fanno mai delle buone, e nell’andata e nel ritorno s’impigliano tra le corna.
La “caccia al becco” era un’usanza simile a quella del capro espiatorio. Secondo la mentalità dell’epoca, il marito tradito si era macchiato di una colpa grave poiché l’adulterio della moglie era considerato un segno di debolezza dell’uomo, di incapacità a controllare la consorte. Sicché nel periodo carnascialesco il becco doveva subire una scherzosa persecuzione rituale: a impartirla erano i defunti impersonati in quella notte dai giovani del villaggio mascherati e chiassosi.
Non scarterei questa interpretazione perché a Nepi, nella Tuscia, fino a qualche anno fa sfilavano per le vie del paese, in una carnascialesca processione profana, molti giovani portando come trofeo e passandosi l’uno l’altro in un rito apotropaico delle corna che dovevano scongiurarne altre. Quanto al simbolo delle corna, sarebbe dovuto al fatto che durante la caccia rituale il marito “colpevole” era identificato con il cervo, preda per eccellenza dei cacciatori: il cervo dalle grandi corna.
Alfredo Cattabiani, Lunario. Dodici mesi di miti, feste, leggende e tradizioni popolari d’Italia, Milano, Mondadori, I edizione Oscar saggi, 2002, pp. 364-369.