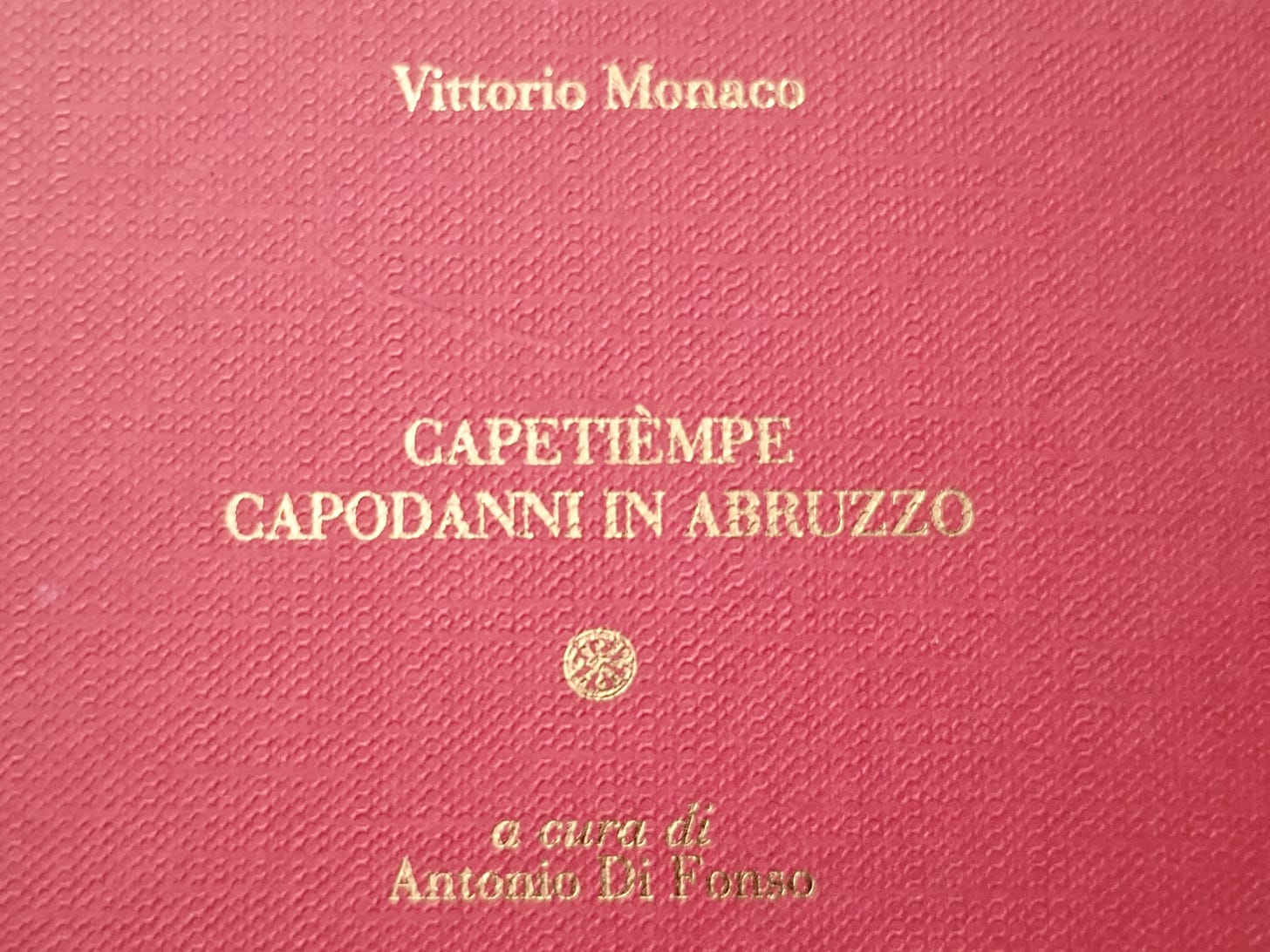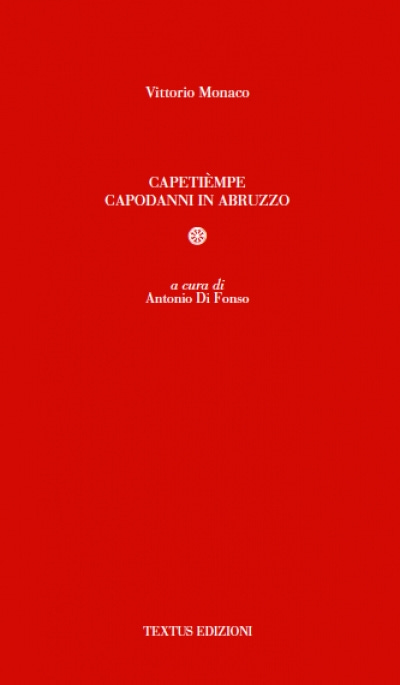Capotempo
Il sentimento circolare del tempo nella cultura popolare e il “capodanno contadino” a inizio novembre, con particolare riferimento alla Valle Peligna, in Abruzzo
È la fine di ottobre, è tornata l’ora solare, al pomeriggio si fa scuro presto, di giorno e soprattutto di sera comincia a volerci uno strato di vestiario in più o uno più pesante. È vicina anche la commemorazione dei defunti, e per chi lo festeggia c’è Halloween. Fatto sta, si dia peso o no o queste ricorrenze, non sono giorni qualunque: è un momento dell’anno in cui, più che in altri periodi, si coglie, a un livello tanto esteriore quanto interiore, un forte rimestio. Sono evidenti i segnali di qualcosa che finisce e, allo stesso tempo, di qualcosa che, sottotraccia, rinasce. (È, del resto, anche il periodo in cui, completati i raccolti, in campagna si preparano i terreni per le semine autunnali e invernali.) Per noi moderni, che abbiamo una concezione lineare del tempo, tutto ciò mette un po’ a disagio, siamo parecchio confusi, talora impauriti. La cultura popolare, specie quella contadina, più legata a una concezione del tempo circolare, viveva invece questo momento con maggiore naturalezza ed esorcizzava le paure scatenate da questo rimescolio di forze con una serie di riti e festeggiamenti che si protraevano da Ognissanti al giorno di San Martino, l’11 novembre. Un periodo che in tal modo assumeva i caratteri di un vero capodanno e che in Abruzzo, in particolar modo nella Valle Peligna, intorno a Sulmona, andava sotto il nome di Capotempo (Capetièmpe): “capo del tempo”. Ne dà una ricca illustrazione un bellissimo libro di Vittorio Monaco ripubblicato nel 2019 da Textus Edizioni (L’Aquila), per la cura di Antonio Di Fonso: Capetièmpe. Capodanni in Abruzzi. Con l’autorizzazione dell’editore, che ringrazio, riporto alcuni passi dalle pagine 5-13.
| di Vittorio Monaco |
La modernità ha una concezione lineare del tempo. Il concetto di evoluzione biologica degli esseri viventi e lo studio della storia delle ere geologiche impongono di prendere atto dell’enormità della scala dei tempi passati e dell’irreversibilità delle trasformazioni verificatesi. Con l’astrofisica, l’idea di evoluzione, storia e irreversibilità è diventata la visione dell’intero Universo. Oggi, la percezione che abbiamo del tempo è quella di un flusso continuo di macro e micro-eventi che accadono e si dissolvono su una linea di fuga senza ritorno. Le figure rappresentative di questo movimento sono la linea retta, senza inizio e senza fine, e la freccia a senso unico, puntata dal passato al futuro. La loro unidirezionalità implica l’irreversibilità della vita: di quella del cosmo, concepito come Universo in espansione, e di quella dell’uomo, orientata unicamente sul futuro e perciò sempre tesa e divisa tra speranza e paura. L’enigma di un tempo che fugge (e ci sfugge) diventa l’enigma del senso. Non si dà ritorno dalla morte alla nascita: la vita, come ogni altra serie di eventi, sporge per un momento dal nulla e vi rientra. Il fluire del tempo è il suo destino.
Nella cultura della tradizione popolare vigeva un’idea diversa. La comune esperienza dell’alternarsi del giorno e della notte, il ripetersi annuale delle opere e dei giorni della società contadina, la scansione dei mesi lunari e l’avvicendarsi delle stagioni suggerivano l’idea di un tempo circolare, che torna periodicamente sui suoi passi. Anche la vita dell’uomo, presa nella circolarità del tempo cosmico, si riteneva che non finisse con la morte, ma continuasse in forma diversa nell’oltretomba, per poi tornare di nuovo in circolo. Il tempo lineare della breve durata della vita dei singoli individui veniva ricompreso in quello circolare e sempre ricominciante del cosmo. In analogia con il seme che morendo rinasce e si riproduce nella pianta che genera, i nipoti erano considerati renàsceta (rinascita) degli ascendenti. L’uomo agricoltore sapeva da sempre che «la terra contiene i germi misteriosi della vita e, se la morte rimanda ad essa tutti gli esseri, li richiama a novella esistenza dal mondo sotterraneo».1 […]
Accanto alla ruota [e al circolo], l’altra immagine adatta a rappresentare il tempo che ogni volta finisce e ricomincia, muore e rinasce da capo, come la fenice dalle proprie ceneri, è l’anello che gira su se stesso o il serpente che si morde la coda. D’altronde il senso della circolarità è insito nell’etimo stesso della parola ‘anno’: annus, dal latino arcaico an per circum, significa tanto ‘anno’ quanto ‘anello’ (annulus). Tuttavia, l’eterno ritorno non va inteso come un processo garantito da una necessità meccanica. C’era sempre la possibilità, sia pure remota, che l’anello del tempo si spezzasse in uno dei punti deboli, se fosse venuta meno la partecipazione dell’uomo al suo farsi e rifarsi. Per la mentalità popolare arcaica la natura è un organismo vivente, mosso da forze misteriose, di cui l’uomo è una componente essenziale. L’interazione dell’uomo con la natura è così intensa e completa che egli non può osservarla dall’esterno: è dentro di essa, è attraversato egli stesso dalle linee di forza che fanno funzionare il mondo e partecipa in modo costante e attivo a questa pulsione cosmica. Perché il moto circolare del tempo segua il suo corso normale, sono necessari rituali e festeggiamenti che accompagnano il tempo che passa e accolgono quello che viene: la luna calante o nuova non riprenderà il suo primo splendore senza gli esorcismi umani, il campo non darà il raccolto senza le offerte rituali, tanto obbligatorie quanto l’aratura e la semina. […]
Uno dei punti fragili dell’anello del tempo era costituito dalla crisi autunnale, quando con gli ultimi raccolti, la battitura dei fagioli, la spannocchiatura del granturco, la rimessa della legna per l’inverno, la vendemmia e la vinificazione, si chiudeva il ciclo produttivo dell’anno. […]
In quei giorni la natura appare stremata. Le ore di insolazione diminuiscono a vista d’occhio; l’ultimo sole, ogni giorno più pallido, splende senza calore sulle vigne vendemmiate; le giornate si intorbidano di nebbie; gli alberi si spogliano; migrano gli uccelli. Il paesaggio presenta un’immagine da fine del mondo.
Con il venir meno della luce, per la mentalità arcaica entrava in crisi la continuità del tempo. E poiché l’anno è solare, cioè mosso dal sole, l’agonia della luce rappresentava un rischio di sospensione cronologica e di ritorno del mondo al caos delle origini. Allora gli elementi naturali sembrano confondersi tra loro: acqua, cielo, terra fluidificano in una miscela informe. Gli ‘inferi’ e i ‘superi’, mondo di sotto e mondo di sopra, si incontrano su uno stesso piano. Nel rimescolamento generale i morti uscivano dalle sedi sotterranee e tornavano a invadere lo spazio dei vivi: l’ordinaria distinzione/separazione tra luogo dei morti e luoghi dei vivi era abolita e i cimiteri cessavano di delineare il recinto riservato (o imposto) ai defunti.
Pure, in questo scenario dominato dal senso della fine, fermentavano i germi di una vita nuova. I semi erano stati seminati. La conclusione di un anno agricolo si incontrava con l’inizio dell’altro. I campi venivano concimati: Dde’ fa li mirécule ’n cile e lu fumire li fa ’n terre (Dio fa i miracoli in cielo e il letame li fa in terra).2 Si riscuotevano i fitti dell’anno che finiva e si rinnovavano i contratti scaduti o si stipulavano i nuovi.
Questo periodo, nella Valle Peligna, andava sotto il nome di Capotempo (Capetièmpe). I riti che vi si praticavano, legati al ritorno dei morti, erano a tutti gli effetti riti di capo d’anno e si svolgevano nei primi giorni di novembre (Ognissanti e Commemorazione dei defunti) e in quello di San Martino. Essi avevano lo scopo di aiutare il sole a superare la crisi, reintegrandone la luce e il calore declinanti con fiaccole e falò (riti solari); di placare i morti e restituire ai vivi la titolarità del mondo di sopra (riti funebri, riti di purificazione); di contribuire a saldare l’anello e a riavviare il tempo (riti di passaggio); di propiziare la sinergia tra il lavoro dell’uomo e le potenze del sacro (riti di fertilità):
Sic semina sicca virescunt
iam mortua iamque sepulta
quae reddita caespite ab imo
veteres meditantur aristas.3
Così il seme secco, già morto
e sepolto, riprende – e dall’ima
zolla risorto,
prepara le spighe di prima.
L’autore
Vittorio Monaco (Pettorano Sul Gizio 1941 – Larino 2009) ha insegnato italiano e latino ed è stato preside di scuola media superiore. Per molti anni è stato intensamente impegnato come dirigente politico, consigliere comunale, assessore e sindaco. Come studioso si è interessato di cultura popolare e di letteratura italiana in lingua e dialetto. Ha promosso e collaborato a iniziative, associazioni culturali e riviste. Ha pubblicato varie raccolte di poesie: da Castagne pazze nel 1977 a Nevelle e altre vie uscito postumo nel 2009. Tra gli altri scritti, il saggio sulle tradizioni popolari Capetièmpe è uscito in prima edizione nel 2003. (Nota biografica tratta dal sito web del Centro Studi e Ricerche “Vittorio Monaco”.)
Il libro
Vittorio Monaco, Capetièmpe. Capodanni in Abruzzo, a cura di Antonio Di Fonso, Textus Edizioni, L’Aquila 2019, pp. 208, € 15,00. Il volume, dal 20 di ottobre a Natale, è in promozione a un costo di € 14,50 spedizione compresa. Per eventuali ordini si può inviare una email all’indirizzo info@textusedizioni.it oppure telefonare al 347 7908603.
G. Pansa, Miti, leggende e superstizioni dell’Abruzzo, vol. I, Edit. Caroselli, Sulmona 1924, p. 115.
L. Anelli, Proverbi vastesi (1897), Forni, Bologna 1980, p. 96.
Prudenzio, Cathemerinon, X, 101-104.