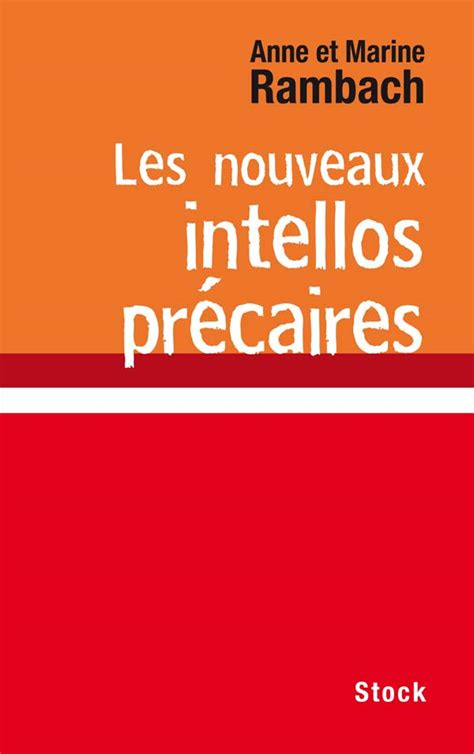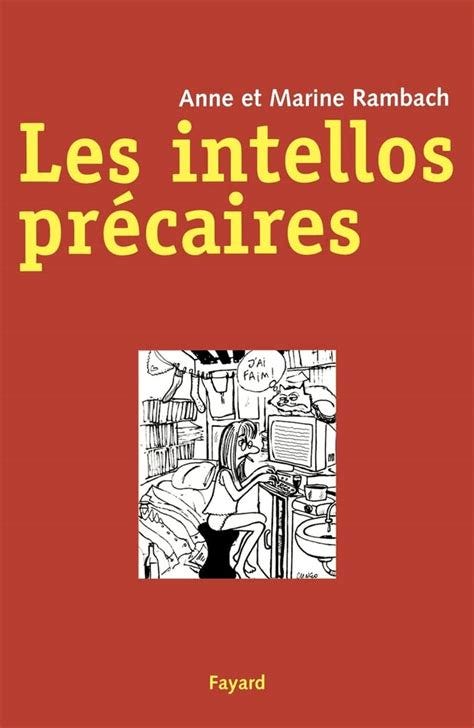Post domenicale #1
A proposito di discussioni nella bolla online del mondo culturale italiano e due vecchi libri francesi sugli intellettuali precari
Si chiude una settimana (se ci atteniamo al vecchio calendario contadino, la prima del nuovo anno lavorativo, scattato all’indomani di San Martino) che nella bolla online del mondo culturale italiano ha visto molte discussioni sul tema del lavoro culturale e di quanto poco venga remunerato, il tutto partito da un post di Jonathan Bazzi su Instagram, con uno screenshot del suo conto corrente.
Premetto che non ho avuto il tempo (ero e sono tuttora impegnato nei lavori agricoli per la semina autunnale. Perché la mia realtà è questa: è vero che faccio il traduttore editoriale – se e quando mi vengono proposte delle traduzioni alla mia portata e di mio gradimento – ma di primo mestiere risulto un coltivatore diretto – è sotto tale dizione che verso i miei contributi pensionistici – e, per quanto sia faticoso e anche renda pochissimo, mi sforzo di portare avanti la piccola azienda agricola familiare nella quale lavoro da sempre, da quando era ancora un ragazzino) e un po’ nemmeno la voglia di seguire per filo e per segno gli innumerevoli contributi in materia, sparsi sulle varie piattaforme (d’altra parte, non sono più Facebook, così come non sono mai stato su Instagram), sicché ho giusto spigolato qualcosa su Substack (dove tra le altre cose ho letto un bel post riassuntivo di Christian Raimo, per Appunti) e sul blog di Loredana Lipperini, che ha dedicato alla questione quattro post (1, 2, 3 e 4).
In ogni caso, mi è tornato in mente una lettura dell’ottobre del 2001 (sì, avete letto bene: autunno 2001, ventiquattro anni fa): Les intellos précaires, un libro inchiesta di Anne Rambach e Marine Rambach, pubblicato da Fayard, sulla condizione degli “intellettuali precari” in Francia. Nel 2009 le autrici ne hanno anche scritto una versione ampliata e aggiornata, Les nouveaux intellos précaires, pubblicata da Stock. Varebbe la pena leggere entrambi (anche se il primo sconta il limite di usare ancora i franchi anziché l’euro, quando riporta esempi di compensi), perché fanno capire che la situazione non investe soltanto l’Italia e, soprattutto, è da tempo che si trascina.1
Prima di risalire su un trattore, propongo giusto qualche passo dal primo libro, in una mia traduzione estemporanea dell’epoca in cui uscì.
Buona domenica!
Schiavitù volontaria
| di Anne e Marine Rambach |
C’è [...] una grandissima differenza tra i precari tutto sommato felici e i precari supersfruttati. I ritratti leggeri dei freelance della moda e dei dottorandi che faticano a sbarcare il lunario pur divertendosi non devono far dimenticare quest’altro aspetto della precarietà degli intellettuali: la miseria, l’insicurezza, lo sfruttamento. Che attraversi una popolazione divisa tra “precari felici” e “precari infelici”, oppure uno stesso individuo che da un lato vive la sua precarietà con buonumore ma dall’altro conosce momenti molto difficili, la distanza esiste. Tra l’intellettuale precario in depressione nervosa, costretto a richiedere l’assistenza sociale, e l’intellettuale precario che si arrangia di contratto in contratto, la differenza può risultare enorme. Ma non c’è niente di positivo nella precarietà dei guardiani notturni all’università: solo povertà, umiliazione, angoscia.
Questa è una delle difficoltà del nostro tema: copre situazioni molto disparate e descrive una popolazione che ha imparato a venire a patti con pratiche scandalose.
Negazione
“Non capisco perché non ci si ribelli di più!”: un’esclamazione ricorrente nelle nostre interviste. Gli intellettuali precari covano infatti la loro collera, la rimuginano, la rimasticano, ma non la lasciano scoppiare. I precari nel loro complesso sono in una posizione troppo brutta per esprimere il proprio disgusto. In questo campo gli intellettuali non sembrano pronti a giocare il ruolo di esploratori, tutt’altro; in un certo senso, incarnano piuttosto la retroguardia. […]
Esistono vari motivi.
Il primo è il carattere discrezionale del lavoro. Come abbiamo già detto, la maggior parte degli impieghi in questi settori si ottiene tramite conoscenze e per cooptazione. È un lavoro offerto con il sorriso, da un volto affabile, familiare, se non addirittura amichevole; e poiché è prezioso, lo si accetta con tanta più riconoscenza. Sarebbe perciò ingrato criticare il compito affidato: “A caval donato non si guarda in bocca”. Poi, mettere in discussione le condizioni di questo lavoro equivarrebbe a ridiscutere la natura del legame che lega al datore di lavoro o all’intermediario.
In secondo luogo, la figura dell’intellettuale, in quanto “coscienza”, continua ad avere il suo fascino. I nuovi arrivati idealizzano il loro ambiente in modo straordinario. Quando si confronta l’idea che gli allievi giornalisti si fanno del loro futuro ambiente di lavoro con la realtà dello stesso ambiente oggi, il divario è sconcertante. Stesso discorso per l’editoria o la ricerca. Questi settori conservano un prestigio non solo intellettuale ma anche morale: dai loro membri ci si aspetta una forma di disinteresse, quasi di devozione. Il lavoro intellettuale continua a essere percepito come una forma d’impegno. Per quanto questa affermazione possa apparire ingenua, nulla toglie che una simile aspettativa esiste davvero nei nuovi arrivati, e anche in chi vi ha passato abbastanza tempo da conoscerne le ipocrisie, le violazioni, i tradimenti.
Ma la negazione è generale. I primi a negare sono del resto gli stessi precari. Che impiegano molto prima di pronunciare a mezza voce le prime critiche. Ma in chi continua a vivere nella precarietà, l’indignazione è tanto più forte quanto più questa ha covato a lungo. Ci ha colpito la rabbia dietro molte delle dichiarazioni, elemento tanto più sorprendente perché pochi attimi prima le stesse persone definivano i rapporti con il datore di lavoro “buoni”, “cordiali”, “affettuosi”. È un aspetto pressoché ricorrente: i precari vedono nel loro direttore, editore, caporedattore e via dicendo una “bella mente”, ma quando gli si chiede di analizzare i motivi della loro frustrazione è presto una valanga di constatazioni amare e di giudizi sprezzanti. Molti mandarini e intellettocrati si saranno sentiti fischiare le orecchie durante i nostri mesi d’inchiesta…
Prima constatazione: “Un elemento duro, in questo contesto, è che ci si trova davanti a persone che non si pongono minimamente il problema di come fai ad arrivare a fine mese”. L’intervistata è giornalista in un settimanale di sinistra. Ed è vero, lo dicono tutti: c’è un disinteresse totale per la loro sorte, una completa mancanza d’attenzione per questa domanda eppure fondamentale: “La persona con la quale lavoro o che faccio lavorare ha di che mangiare?”. Questo non sorprende quando si tratta di un datore di lavoro occasionale; diventa spaventoso quando il datore di lavoro è regolare, se non addirittura l’unico. L’indifferenza, un giorno, è dolorosa; sei mesi, un anno, due anni, è odiosa.
L’altra molla della negazione è il senso di elitarismo: “Sei tra gente di buona famiglia, con buone referenze; ti comporti in buonafede”. […] Si tratta di un elitarismo strutturale che riposa su un contratto implicito (del resto, assolutamente tradizionale): per un po’ fai i lavori di bassa manovalanza, dopo di che sarai accolto tra l’élite (l’università, il giornale prestigioso, l’istituzione culturale ecc.). Questo sistema ha sempre funzionato in modo così meraviglioso che non si vede perché oggi non dovrebbe farlo più. Ma oggi, crise oblige, il tempo d’attesa e lo sfruttamento “iniziatico” spesso durano troppo a lungo. La precarietà si protrae per mesi, anni. Il riconoscimento statutario non arriva. E questo a volte finisce per aprire gli occhi.
Anne e Marine Rambach, Les intellos précaires, Parigi, Éditions Fayard, 2001, pp. 250-254.
Sul Corriere della Sera del 25 giugno 2024, Paolo Fallai ha proposto il neologismo “intellettuario” per indicare la figura dell’intellettuale precario. Vedi l’articolo “Intellettuario, quando studi, ti impegni e resti un precario. Un neologismo per un vizio antico degli ignoranti: svalutare il lavoro e la competenza di chi ha studiato”.